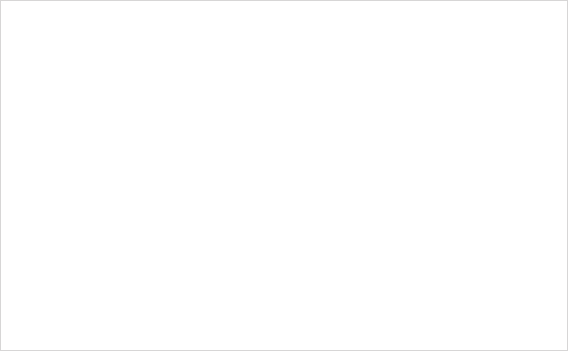
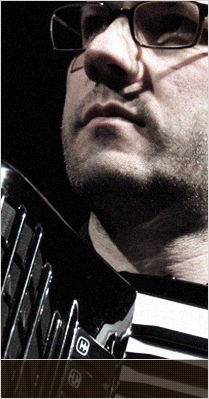
Perché fare musica antica con la fisarmonica?
La moderna ricerca filologica applicata al repertorio antico negli ultimi decenni ha allargato i propri orizzonti e, superando i legami che la univano al rigoroso utilizzo di strumenti (o di copie di strumenti) d’epoca, ha focalizzato la propria attenzione sul linguaggio, ammettendo anche esecuzioni, pur consapevoli e rigorose, di brani antichi su strumenti moderni.
La fisarmonica non è sicuramente uno strumento antico. Inizia a definirsi alla fine dell’Ottocento e, dopo una lunga serie di innovazioni tecnologiche, fa il suo ingresso nell’ambito degli strumenti “classici” nella seconda metà del XX secolo.
Possiede, però, due caratteristiche che la rendono particolarmente credibile nella riproposizione del repertorio antico: può essere collocata sulla linea evolutiva degli organi portatili e possiede doti di brillantezza e di chiarezza del suono che ne avvicinano il timbro alla sonorità del clavicembalo e degli strumenti affini.
A me piace definirla una “sintesi” delle tastiere antiche e, in quanto tale, la ritengo un mezzo idoneo e talvolta, paradossalmente, addirittura “ideale” per l’esecuzione di una buona parte del repertorio solistico e cameristico per tastiere del ‘600 e del ‘700.
Lo strumento che utilizzo fa un ulteriore passo verso la sonorità degli strumenti “storici” essendo, al momento, l’unica fisarmonica esistente con il La a 415hz e accordata secondo il sistema Vallotti.



di Giorgio Dellarole